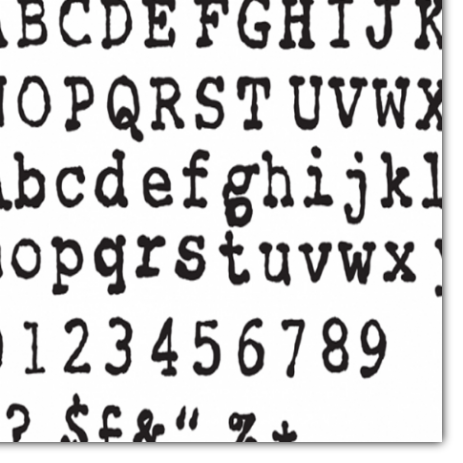IL GIOVEDÌ GRASSO E IL CAMPANELLO
about me > TITOLI > 2016
Foto di Scena realizzate da
FOTO PICCINNI -TREVISO
RECENSIONI - REVIEWS

DUE SPLENDIDE FESTE DI CARNEVALE
Trama del progetto drammaturgico
Atto primo:
Il farmacista prende moglie
Don Annibale Pistacchio, farmacista, prende in moglie la giovane e bella Serafina. L'azione si svolge nel periodo di Carnevale, a Foria, alle porte di Napoli, in casa dello sposo. La festa impazza, e gli invitati hanno appena lasciato il lauto banchetto per cominciare le danze. Annibale ha una fretta indiavolata: chiamato a Parigi per l’apertura di un testamento che lo potrebbe fare ricchissimo, ha pochissime ore per consumare il matrimonio. La sua tempestiva presenza dinnanzi al notaio è necessaria per ricevere l’ eredità. La neo-suocera Rosa lo rassicura promettendo che vigilerà sulla figlia durante tutta la sua assenza.
Arriva intanto, non invitato, Enrico, ex amante corrisposto di Serafina. Abbandonato dalla ragazza a causa di ripetute infedeltà, protesta animatamente il suo amore cercando di convincerla a eiprendere la relazione. La novella sposa apparentemente non cede.
Per dispetto, vedendo sopraggiungere don Annibale, Enrico si getta ai piedi di Serafina fingendo una lite tra innamorati. Alle accuse, il giovane risponde prendendo in giro il povero marito e facendogli credere di essere in realtà impegnato a provare la scena di una commedia studiata proprio per essere declamata in occasione della festa di nozze, come personale omaggio agli sposi. Don Annibale non vuol sentire storie, ha fretta di concludere i festeggiamenti per restare finalmente solo con Serafina. Ma davanti alle insitenze dei convitati è costretto a cedere. Enrico si esibisce dunque improvvisando un’improbabile, buffissima azione drammatica. Allo scoccare della mezzanotte però il padrone di casa non ne vuole più sentire e, seppur faticosamente, riesce a liberarsi degli ospiti.
Rimasto solo con il servo Cola, don Annibale si fa aiutare ad indossare le vesti da camera. Il suo timore è ora quello che qualcuno, bisognoso di cure, suoni il campanello. Il servo non lo potrà sostituire in tale evenienza: un decreto governativo impone infatti che tutti gli speziali vendano di persona le proprie droghe, sotto pena di multa e di arresto. Ovviamente, non appena il poveretto si avvia verso la camera da letto dove la sposa lo aspetta, il famigerato campanello si mette a suonare.
Il malato febbricitante che si presenta a casa dello speziale in cerca di rimedi, altri non è che Enrico, travestito da damerino francese, ben fermo nel proposito di rovinare la prima notte di nozze al rivale. Mentre don Annibale esce di stanza, cercando il rimedio desiderato dal cliente – cinque o sei bottiglie di Porto –, Enrico attua il suo piano infilando un bigliettino nella serratura della porta della camera da letto, spostando i mobili della stanza e spegnendo il lume. Al suo rientro, il farmacista trova la stanza immersa nel buio. Enrico finge di scusarsi per aver fatto cadere inavvertitamente il lume, don Annibale lo accompagna alla porta. L’ oscurità non aiuta certo lo sposo a raggiungere la sposa, tantopiù che i mobili sono stati spostati e non vi sono più punti di riferimento. Quando, dopo varie peripezie, don Annibale riesce a riaccendere il lume e ad avviarsi verso la sospirata meta, il campanello suona di nuovo.
Questa volta Enrico ha preso le sembianze di un cantante del Teatro Nuovo disgraziatamente “giù di voce” il giorno precedente al suo debutto ne Il Campanello... Lo speziale gli propina una dose di pillole per la gola che costui ingurgita non prima di aver spiegato dettagliatamente, e lungamente, la causa dell’ accidente. Solo dopo una seconda dose e numerosi gorgheggi, il “cantante” se ne va. Furibondo, don Annibale si consola pensando alla bella Serafina che lo attende, sta per abbassare la maniglia della porta ma lo ferma il bigliettino infilato nel buco della chiave: è una minaccia. Egli non deve coricarsi quella notte, se vuole aver salva la vita. Chiamato a gran voce, accorre Cola. I due immaginano che il biglietto sia opera di Enrico e decidono di ignorare l’ avvertimento: don Annibale dormirà ugualmente con Serafina. In caso di intrusioni, una manciata di petardi davanti alla porta della camera matrimoniale, scoppiando, sveglierà il buon Spiridione che provvederà tempestivamente a chiamare le guardie.
Il campanello suona ancora: una vecchia cela le sembianze di Enrico. Dopo un confuso racconto delle principali sventure della sua vita, chiede insistentemente dei medicamenti. Partita la “donna”, lo sposo, esasperato, ha deciso: non aprirà più a nessuno. Corre verso la camera ma i petardi scoppiano sotto i suoi piedi. Il frastuono sveglia l’ intera casa e il vicinato. E riecco che suona il campanello. Ormai è mattino ed Enrico, con tutti i parenti, è venuto a salutare la partenza di don Annibale per Parigi.
Atto secondo
Don Annibale diventa Parigino
Sono passati quattro anni, Annibale ha ereditato casa e sostanze dalla defunta zia di Parigi e ha lasciato la faticosa professione di farmacista stabilendosi nella capitale parigina con tutta la famiglia, anche per allontanare Serafina dalle attenzioni dell'amante Enrico. Da perfetto parvenu segue la moda parigina e ha cambiato il nome in Sigismonde Futet, mentre la consorte Serafina ora ha preso l'identità di Camille, da un dramma di Nicolas Dalayrac di gran moda in quegli anni. L'azione si svolge nei dintorni di Parigi durante il Carnevale. Nella ricca casa del Colonnello si sta consumando un piccolo dramma. Nina, la giovane figlia del padrone di casa è innamorata del giovane e timido ufficiale Teodoro. Il Colonnello, all'oscuro di tutto, ha promesso in sposa la ragazza ad un amico di Limoges, Ernesto di Rousignac. Il promesso sposo sta per arrivare in casa, ma è Giovedì Grasso, e così agli amici di Nina e Teodoro viene in mente di burlarsi del pretendente per rispedirlo a Limoges. A guidare la congiura è Sigismonde che -con una certa presunzione- progetta di ispirarsi nientemeno che al Signor di Pourceaugnac di Molière. Nella commedia del grande drammaturgo francese, infatti, un gruppo di parigini si prende gioco di un borghese venuto da Limoges per cercar moglie. Sigismonde si travestirà dunque da Piquet, avvocato e immaginario amico di famiglia dei Rousignac. Nella sceneggiata la moglie Camille, dovrà recitare la parte di una amante che reclama riparazione per essere stata sedotta e abbandonata da Ernesto. Il piano prevede che il finto avvocato Piquet, sentendo tale accusa, prenda la difesa di Camille e minacci a gran voce di far causa, portando davanti al giudice il malcapitato "fedifrago". Ernesto di Rousignac, spaventato, dovrebbe in questo modo scappare a gambe levate, tornando a Limoges e lasciando libera la giovane Nina. Il piano viene approvato entusiasticamente da tutti, ma Madama Rosa (che a Parigi lavora come governante), quando si presenta alla porta Rousignac (un distinto e intelligentissimo ufficiale) lo introduce in casa equivocando sulla sua identità. Crede si tratti d'un amico accorso a dar man forte per la messinscena. Non solo: gli spiffera il piano in ogni dettaglio. Ernesto, offeso dalla supponenza e dallo sciovinismo dei parigini, decide di stare al gioco e di dar una lezione a tutti quanti. Si traveste da campagnolo e scrive due lettere. Nella prima richiama in casa urgentemente il Colonnello (che è stato allontanato con un pretesto), nell'altra chiede un appuntamento a Camille, trattandola come se fosse veramente la sua amante. Il piano funziona a perfezione: Ernesto riesce a far ingelosire Sigismonde, che litiga furiosamente con la moglie; il vecchio servo napoletano Cola viene quasi bastonato per aver recapitato il messaggio d'appuntamento; Teodoro si convince che l'adorata Nina ha una tresca con Giulio, un sottotenente suo amico. Al colmo della confusione sopraggiunge finalmente il Colonnello. È il momento della verità: Ernesto rivela di aver architettato il piano e di essersi trasformato da vittima in vendicatore. Infine, dopo aver impartito la lezione ai "congiurati", rinuncia alla mano di Nina e intercede nobilmente presso il burbero Colonnello affinché conceda il permesso di matrimonio ai due giovani amanti, che finalmente possono rivelare la loro relazione. La pace è fatta e la verità ristabilita. Possono finalmente cominciare i festeggiamenti del Giovedì Grasso nella felicità di tutti i convenuti.
Crudeltà ed ethos:
due volti della farsa donizettiana
A proposito dei testi messi in scena
Gaetano Donizetti è l'ultimo grande autore di melodrammi ad aver intensamente lavorato, lungo tutta la sua carriera, sul genere comico. Il cartellone 2016 del Comunale di Treviso ci permette un interessante approfondimento sull'ambiente napoletano e sulla enorme varietà di sfumature che la commedia in musica aveva prodotto fra Sette e Ottocento, contribuendo in maniera sostanziale al mercato dell'opera di quell'epoca.
Il campanello, farsa con dialoghi in un atto, fu battezzata Il primo giugno 1836 al Teatro Nuovo di Napoli. La produzione si collocava nel pieno di una crisi profonda dei teatri partenopei. Il 31 gennaio di quell’anno Maria Cristina aveva dato alla luce il tanto atteso erede al trono dei Borbone, ma dopo il parto la regina era morta di setticemia, lasciando nella più cupa prostrazione Ferdinando II. I palcoscenici avevano sospeso le programmazioni per rispettare il lutto cittadino, mentre il S. Carlo non riuscirà a riaprire neppure il 13 febbraio, alla fine del decretato periodo di chiusura: lo impediva un deficit finanziario causato da mala gestio. Leggermente meglio andava per i teatri “minori”; al Nuovo, in particolare, un intendente capace, Filippo Pellegrino, si era arrischiato a mettere sotto contratto una compagnia di buon livello per sostenere la stagione. Ma, essendo la capienza di quella sala piuttosto limitata, l’impresario chiedeva alla soprintendenza il permesso di aumentare le recite per recuperare il denaro con uno sbigliettamento più intenso. La licenza fu accordata: in effetti Pellegrino si era pericolosamente indebitato ed era sull’orlo della bancarotta. Donizetti, il più famoso operista attivo in quegli anni, l’autore di Anna Bolena, Elisir, e Lucia contribuì personalmente al salvataggio della situazione del Nuovo con generosità impareggiabile: nessun poeta voleva scrivere in fretta e furia un libretto senza avere garanzie di ritorno economico? Il compositore mette a frutto il suo istinto teatrale per trasformarsi in librettista. L’impresario aveva una fretta indiavolata perché assediato dai creditori? Pochissimi giorni di tempo e la partitura era pronta. Per Donizetti otto giorni per un lavoro di queste dimensioni rappresentavano in assoluto un tempo ragionevole. Donizetti prese come soggetto un vaudeville dal titolo La sonnette de nuit, scritto da Brunswick, Barthélemy e Lhérie e rappresentato pochi mesi prima (il 27 novembre 1835) al Théâtre de la Gaité di Parigi. Donizetti non presenziò a quella serie di recite (era a Genova); si accostò dunque alla pièce leggendone il testo, su consiglio – pare – dell’amico editore Guglielmo Cottrau; lo tradusse in italiano e adattò secondo le proprie esigenze. Ebbene (e mi riferisco in particolare ai dialoghi parlati), l’uso che il compositore fa della lingua napoletana rivela una padronanza del lessico e dei costrutti pressoché perfetta, comprese alcune allusioni locali e giochi di parole che in teatro dovevano sortire un effetto di comicità dirompente.
Alla prima presero parte Raffaele Casaccia (figlio del celebre Carlo, nel ruolo di Don Annibale Pistacchio), Giorgio Ronconi (nel ruolo di Enrico), Giovannina Schoultz (nel ruolo di Serafina), mentre non abbiamo notizie sugli interpreti delle due parti d’appoggio, quelle di Madama Rosa e Spiridione, sicuramente modesti cantanti comprimari o attori di rango locale. La compagnia sfruttava dunque la presenza in cartello di un’unica vera star, il baritono Giorgio Ronconi (1810-1890) per il quale Donizetti creò alcuni fra i ruoli più rilevanti di tutta la sua produzione: Cardenio ne Il furioso all’isola di S. Domingo, Torquato nel Torquato Tasso, Nello in Pia de’ Tolomei, Corrado in Maria de Rudenz, Don Pedro in Maria Padilla, Chevreuse in Maria di Rohan. Non è dunque un caso che per gli interpreti moderni il ruolo di Enrico, dalla tessitura così acuta, variata e talvolta impervia, sia una prova di perizia tutt’altro che trascurabile.
Raffale Casaccia era una celebrità cittadina: apparteneva ad una straordinaria schiatta di comici-cantanti che fin dal primissimo Settecento calcavano le tavole dei teatri napoletani. È l’unico che la critica giudica severamente, perché faceva sfoggio «di lezî e contorcimenti che sono di antichissima scuola» (notizia tratta dal libro di Annalisa Bini e Jeremy Commons, Le prime rappresentazioni dell opere di Donizetti nella stampa coeva).
Il ruolo della giovane Serafina venne sostenuto da una certa Giovannina Schoultz, che gli studiosi hanno lungamente confuso con la ben più famosa Amalia Schültz Oldosi; sempre a Ilaria Narici si deve il ristabilimento della vera identità dell’interprete. Di nuovo posso aggiungere in questa sede che Giovannina cantò anche nell’estate 1837 a Siena, al teatro dei Rinnovati, il ruolo della principessa Matilde in Guglielmo Tell; nell’occasione compare come «Socia Onoraria dell’Accademia Reale di Musica di Svezia e Danimarca», il che mi ha permesso di identificarla con la cantante scandinava Johanna Karolina Von Schoultz (sposandosi assumerà il cognome Brand), vissuta tra il 1813 e il 1863 e presente a Napoli dai primi mesi di quel 1836.
Possiamo dunque immaginare come la distribuzione delle parti fosse particolarmente adatta alle qualità fisiche degli interpreti: una coppia di giovanissimi (23 anni la Schoultz, 26 Ronconi) si contrapponeva al più maturo Casaccia, buffo che recitava da ‘vecchio caricato’ fors’anche per esagerare la sua posizione ridicola all’interno dello spinoso triangolo raccontato dalla trama.
La prima rappresentazione (la farsa era abbinata col primo atto della Pazza per amore di Coppola) ha un successo pieno, il pubblico esulta, la critica applaude in maniera abbastanza compatta e l’impresa del Nuovo è salva. Un anno dopo, Il Campanello approderà al più capiente e nobile teatro del Fondo, il secondo Teatro Reale della capitale borbonica. Per l’occasione Donizetti trasforma i dialoghi in recitativi secchi con l’aiuto del poeta Salvadore Cammarano, ‘toscanizzando’ anche le parti di Don Annibale (e se vogliamo la cosa è paradossale: il libretto con intere sezioni in vernacolo è stato scritto dal bergamasco Donizetti; quello in Italiano dal napoletano Cammarano). Questa seconda stesura, in cui il brindisi è sostituito e compare l’aria aggiunta per Enrico «Mio signore venerato», risponde sostanzialmente alla versione dell’opera che ha circolato – con una discreta fortuna – fino alla pubblicazione della Edizione Critica, nel 1994.
La comicità di Campanello non ha come obiettivo la moralizzazione del pubblico, ma ha come unico scopo il divertimento cinico fondato sulla crudeltà. La crudeltà sul palcoscenico serviva per mettere a nudo i vizi dell’uomo. Perfida la trama: Don Annibale, ricco e maturo farmacista di Forìa (vicino a Napoli) decide di sposarsi per vanità: vuol dar seguito alla dinastia dei Pistacchi (è esattamente lo stesso schema che si troverà nella cavatina di Don Pasquale). La scelta cade su Serafina, ragazza giovane e povera, attraente, tutt’altro che ingenua, figlia di padre incognito, spalleggiata e protetta da Madama Rosa, madre ansiosa di vederla accasata. L’azione ha principio subito dopo la celebrazione del matrimonio: si sta festeggiando con danze e libagioni. Ma sulla prima notte di nozze incombe una minaccia. Enrico, il giovane ex-amante di Serafina, è deciso a guastare la festa allo speziale impedendogli di “consumare”. La leva drammatica grazie alla quale Enrico riuscirà nell’intento, manco a dirlo, è il più grave vizio di Annibale, l’avarizia.
La partitura procede, senza cadute di tono o rallentamenti di ritmo, fino alla fine: le varie incursioni di Enrico vengono trattate con pertinenza ed efficacia, dispiegando tutta l’esperienza comica di Donizetti. Una serie di espedienti tradizionali viene snocciolata costituendo quella che si potrebbe definire una specie di prontuario delle più comuni situazioni farsesche: la parodia della tragedia ‘alta’ di parola (l’improbabile scena tratta da Zasse, Zanze e Zonzo), il plurilinguismo (il francese maccheronico del damerino e il vernacolo), il cambio di sesso (Ronconi nel 1836 al Nuovo si travestì appunto da «vecchia strega»), la tirata del ciarlatano che elenca finti mali e falsi rimedi stile Dulcamara («Mio signore venerato»), la parodia dell’opera seria e dei suoi cantanti (la barcarola del cantante geloso e arrochito che prova la voce). Nel Teatro moderno applaudito, una celebre silloge di testi teatrali pubblicata a Venezia tra il 1796 e il 1801 (vol. 61, p. 82) si descriveva il genere della farsa con queste parole: «In questo genere di componimento tutto dee procedere con rapidità. [...] Per la sua brevità è forse la più difficile delle drammatiche composizioni.» Donizetti dimostra di avere ben recepito la lezione. Il modo in cui il compositore governa il tempo drammatico di Campanello è una delle caratteristiche più raffinate nella drammaturgia della pièce: tutto avviene in maniera estremamente serrata, il succedersi ininterrotto dei molteplici travestimenti lascia gli spettatori senza posa. Enrico s’impadronisce del tempo scenico di tutti gli altri e non lo cede più a nessuno, creando in Don Annibale (e per empatia in noi che pure sediamo tranquillamente sulle poltroncine di velluto) uno stato di ansia crudele. Donizetti suddivide la composizione in quattro sezioni: sono i quattro colpi di campanello (uno idealmente ogni ora) con relativo ingresso di Enrico/Damerino, Enrico/Cantante, Enrico/Vecchio petulante e infine di Enrico/Enrico, che giunge assieme agli amici nei panni di se stesso per “svegliare” lo speziale (che in verità non è mai arrivato neppure in camera da letto). Attraverso lo scorrere delle ore lo statuto della crudeltà viene rispettato in maniera scientifica. Due personaggi sanno che la notte di Don Annibale non è andata secondo le previsioni: Enrico e ovviamente Serafina, che ha dormito da sola. Lo speziale non ha capito che Enrico è l’autore dei travestimenti; perciò non s’inquieta quando, nel salutarlo, il rivale auspica sarcasticamente che «Bella al par di questa notte / Sia la vita ognor per te». C’inquietiamo un poco noi per il comportamento di Serafina: dapprima la sposina intona un larghetto appassionato e dolente di commiato, «Da me lungi ancor vivendo». La scrittura non ha crepe, è ricca di nobile coloratura, potremmo giurare si tratti di un’apostrofe sentimentale sincera. Ma dopo che Enrico – orologio alla mano – si è rivolto a Don Annibale per canzonarlo, lei ha capito finalmente che se ha evitato la notte coll’anziano farmacista è merito del suo ex, e cinicamente (ben sapendo come sono andate in realtà le cose) si unisce alle parole di Enrico per augurare che «Bella al par di questa notte / Sia la vita ognor per te». La notte sarà stata bella per lei. Per il marito, certo, no.
La comicità della seconda opera in programma è di natura molto diversa. Il gioco della crudeltà diventa più filosofico, una piccola "schola", una dimostrazione di cosa possa accadere a chi -presuntuosamente- si mette in posizione di superiorità rispetto agli altri. Il giovedì grasso fu scritta per due fra le voci maschili più famose dell'epoca (Luigi Lablache, baritono, e Giambattista Rubini, tenore) e rappresentata nel 1829 al Teatro Del Fondo di Napoli, nel periodo di Carnevale, anche se i cataloghi -senza però alcuna testimonianza certa- ne collocano la composizione al 1828. Ebbe un considerevole numero di recite, fu ripresa per alcuni anni ed ebbe anche una certa circolazione fuori di Napoli, apparendo quasi sempre con il titolo alternativo de Il nuovo Pourceaugnac. Purtroppo nessun libretto venne stampato in occasione di tali recite, circostanza che complica molto la definizione dell'assetto drammaturgico dell'opera: l'autografo di S. Pietro a Maiella, infatti, manca dei recitativi e/o dei dialoghi di raccordo. La versione con i recitativi attualmente in circolazione deriva da una copia milanese (Conservatorio, Fondo Noseda) e da "un copione" posseduto da Casa Ricordi. Queste fonti manoscritte sono probabilmente la testimonianza d'una ripresa (probabilmente lombarda) più tarda. Allo stato attuale della ricerca dobbiamo dunque considerare quei recitativi come rielaborazione apocrifa del testo originale, andato perduto nella sua completezza. Resta peraltro incerto se al debutto l'opera avesse dialoghi (come sostengono ad esempio Jeremy Commons e Annalisa Bini ne Le prime rappresentazioni delle opere di Donizetti, p. 191) o recitativi (normalmente al Teatro Reale del Fondo le farse avevano recitativi cantati e non dialoghi, ma esistono eccezioni documentate).
Certo è che l'autografo napoletano termina con una dichiarazione del compositore laconica e per nulla chiarificatrice: «mancano tutti li recitativi». Mancano perché il compositore doveva ancora comporli (e questo confermerebbe la protostruttura con dialoghi) o perché erano scritti su altri fogli, andati perduti? Le parole di raccordo all'inizio dei numeri musicali autografi non ci dànno altre informazioni, se non che i recitativi milanesi corrispondono solo parzialmente all'attacco dei numeri musicali originari. E questa è prova indiretta del fatto che le fonti milanesi sarebbero una rielaborazione successiva. Oltretutto i manoscritti di Milano sembrano dimostrare che l'estensore della versione con recitativi avesse attinto direttamente alla commedia originale di Scribe e Delestre-Poirson da cui l'opera derivava.
Il testo che verrà eseguito è dunque un nuovo adattamento con dialoghi. Il testo musicale segue precisamente l'autografo donizettiano, completamente ritrascritto per l'occasione dagli studenti di Opera Studio(1) con il coordinamento di Maria Chiara Bertieri dell'Università di Ferrara e la supervisione di Franco Trinca. I dialoghi sono stati ricreati da me utilizzando come "scheletro" drammaturgico la successione dei recitativi milanesi; su tale struttura ho innestato le battute della commedia di Scribe utilizzando come fonte una traduzione italiana pubblicata in quegli anni.(2)
Questo tipo di lavoro (qualcosa di simile al "restauro" di un affresco in cui le parti mancanti sono reintegrate partendo da fonti, cartoni o disegni preparatorii), permette la lettura di un dramma di gusto raffinato e di ardua scrittura belcantistica.
L'intreccio si basa essenzialmente sul "travestimento" del protagonista (Ernesto di Rousignac, ufficiale di Limoges) che, approfittando dello snobismo d'un gruppo di amici parigini e facendo leva sulle loro debolezze, si vendica d'una beffa ordita ai suoi danni, dimostrandosi superiore per intelligenza, ethos e consapevolezza. La burla, ordita per l'appunto al giovedì grasso per sventare un matrimonio combinato, vorrebbe il protagonista destinato a ripercorrere le sventure dello stupido Signor di Pourceaugnac: il riferimento è a Molière, ovviamente, ma in questa versione la vittima si trasforma in castigatore... Il genere di comicità messa in campo da Scribe e Donizetti (via Gilardoni) può dunque essere ben ricondotto a quel nobilissimo filone che da Aristofane ai giorni nostri risponde al motto di Santolius «Castigat ridendo mores». È in qualche modo una "schola", una lezione pratica di vita che -attraverso il travestimento- educa un'accolita di presuntuosi. I numeri musicali sono scritti con gran senso del teatro e pulizia formale, contemperando la chiave belcantistica (soprattutto dei due protagonisti Sigismondo ed Ernesto) alle esigenze di rapidità ed efficacia della trama. Impressionano notevolmente la cavatina per il tenore N. 2, «Servi, gente!» e il duetto N. 5 «Che intesi, quali accenti!», cimenti di straordinario impegno per gli interpreti. Esemplare, dal punto di vista teatrale, il terzetto N.4 «Piano... piano!» che testimonia come Donizetti alla fine degli anni venti padroneggiasse una raffinata tecnica compositiva che permetteva d'incorporare -all'interno di numeri chiusi azioni, mutamenti, colpi di scena che avrebbero avuto invece sede naturale nei recitativi. E neppure manca, in accordo con la più illustre tradizione partenopea, un chiaro tributo alla bouffonnerie all'italiana con il N. 6 «Mo' che discopierto avimm», esilarante duetto dei due buffi Sigismondo e Cola in vernacolo: come in Molière la congrega degli intriganti parigini contempla anche dei napoletani.
Privilegiando il taglio «moralizzatore» dell'opera, Donizetti dipinge invece a tinte molto poco patetiche le parti sentimentali dell'opera, cosicché i due giovani amanti contrastati (Teodoro e Nina) appaiono più come due ragazzi un po' viziati da educare piuttosto che due vittime da aiutare : basti considerare che non esiste un vero duetto d'amore fra i due, e che il tenore principale non è l'amoroso (come vorrebbe la tradizione), ma il furbo "macchinatore".
1) Giovanni Sparano, Carlo Emilio Tortarolo e Alvise Zambon.
2) Il nuovo pourceaugnac, dal «Teatro di Eugenio Scribe tradotto dal francese», Milano, Stella, 1832. p. 255-308.